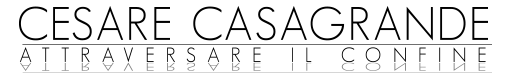Quello che avete tra le mani è un libro denso di immagini, pertanto non serviranno molte parole per introdurlo. Basterà lasciarsi andare, rinunciando al controllo, alla unilateralità della coscienza, all’arroganza egoica, per fare un’esperienza, stimolati dalla visione fotografica.
Dirò, pertanto, soltanto alcune cose.
Vorrei innanzitutto ringraziare Vincenzo che, con leggerezza e soavità, ci ha condotto lungo questo percorso. Un uomo che, se volessimo scolpirlo con l’accetta, potremmo definirlo cristiano, scout, medico. Un medico del soma, ma anche dell’anima, che sa prendersi cura. Questo libro, scritto per i tanti compagni di avventura che con lui hanno condiviso la sua vita lavorativa, lo testimonia.
Partirei da una frase, tratta dalla Seconda lettera ai Tessalonicesi:
E ora sapete ciò che impedisce la sua manifestazione, che avverrà nella sua ora. Il mistero dell’iniquità è già in atto, ma è necessario che sia tolto di mezzo chi finora lo trattiene. (2, 6 – 7).
San Paolo attribuisce il ritardo della parusia, della seconda venuta del Signore nostro Gesù Cristo, a qualcosa o qualcuno che “trattiene”, il katechon. Una forza o una persona che impedisce la manifestazione dell’Anticristo, lo trattiene, lo contiene, e che dovrà togliersi o esser tolta di mezzo, affinché l’Anticristo si disveli pienamente, prima del giorno del Signore. Una identità misteriosa la cui missione, dunque, è porre un argine alla devastazione morale rappresentata dall’insorgere dell’apostasia.
Nelle parole di Massimo Cacciari:
La fine è decisa. Non c’è novitas ancora da scoprire. Ma occorre sopportare con la fermezza del martire l’ultimo assalto dell’antico Drago. E’ la prova che il Signore impone prima della sua vittoria. Tuttavia, appunto, un’altra potenza sembra operare nello spasmo di questo tempo ultimo, sulla cui durata è vano congetturare – una potenza che raffrena l’apocalisse, il disvelarsi perfetto dell’Empio. Ma quando colui che la incarna sarà tolto di mezzo, allora, nulla restando fra l’Avversario e il Signore Gesù, verrà finalmente quest’ultimo a condannare tutti coloro che non hanno creduto alla sua verità. La parola greca è to katechon. (Il potere che frena, di Massimo Cacciari, 2013 Adelphi Edizioni, pag. 13)
Perché il katechon impedisce che l’Anticristo si mostri e, così facendo, ritarda la venuta del Cristo?
Forse Dio, nella Sua infinita misericordia, ci concede altro tempo: un tempo per convertirci, per fare pace con la nostra storia, per tornare a Lui. Noi, che amiamo passarcela bene, non avere problemi, noi che spesso siamo gente di pianura, non amiamo le salite. Quasi non ce la facesse a chiudere definitivamente la saracinesca, per aprire lo scenario del Giudizio Universale.
Detto questo vorrei fare un paragone ardito e provare a cogliere prima nel percorso psicoanalitico, e poi nei sentieri che portano in montagna, nella Natura, nella Wilderness, un katechon, una forza che trattiene e frena l’allontanarsi dell’uomo da se stesso.
La psicoanalisi, potremmo pensarla come una forma di resistenza. Resistenza a cosa? A chi? Resistenza alla superficialità, alla mentalità oggi dominante, a ciò che ci tiene schiavi, al nostro lato oscuro, alla parte patologica.
Questo, forse, vale anche per la montagna, per il Gran Sasso.
In un mondo che cambia troppo rapidamente, in una società capitalistica dove tutto si consuma e si getta via, nulla si ripara o si rammenda, dove si parla troppo, spesso del nulla, la montagna ci dà una testimonianza muta.
E’ lì, ci aspetta, in silenzio.
Fedele, non traditrice, leale, sincera. Perfino benevola, se la trattiamo con rispetto e accettiamo i limiti che essa ci pone. Se non ci perdiamo nel suo contrario, il dionisiaco, l’orgiastica assenza di limiti.
In una società che si sgretola, nella quale gli esseri umani non sono più un fine ma un mezzo, la montagna rimane impavida, tetragona, ferma su se stessa, serena, severa. Almeno fino a quando il cambiamento climatico non la colpirà troppo duramente.
Costituisce un “Altrove”, con tante sfaccettature. Luogo di ristoro, luogo con il quale cimentarsi, luogo di solitudine nutriente, luogo di preghiera, luogo ascendente, verticale, quasi tendente al trascendente. Soglia tra il conosciuto della propria tana e lo sconosciuto che ne sta fuori.
Luogo che richiede l’accesso alla propria “capacità negativa”, per rimanere nella scivolosità e precarietà del perdersi, del ghiaccio sotto i piedi, del vuoto, dell’abisso. E’ l’attitudine del funambolo, o del trapezista che per un momento, lasciato un trapezio e non avendo ancora preso l’altro, svetta nel vuoto.
E sappiamo che l’abisso chiama l’abisso. Recita il Salmo 64, versetto 7: “un baratro è l’uomo e il suo cuore un abisso.”
La natura è anche il luogo dei “sentieri interrotti”, dei quali parla Heidegger. Ma spesso un perdersi è già un ritrovarsi. Spesso occorre smarrirsi, disorientarsi, per trovare un nuovo orientamento, per cogliere dov’è il nuovo, l’oriente. “Strappare lungo i bordi”, di Zerocalcare, è il titolo di una serie tv di successo, su Netflix. Si parla, già nel titolo, dei percorsi obbligati, e ci danno, questi bordi, una illusione di sicurezza. Il contrario dei sentieri interrotti che tanto piacevano ad Heidegger, che lo portavano a perdersi nella Foresta Nera. Esperienza da lui descritta come altamente emozionante e densa.
L’uomo si abitua facilmente a tutto, e questo a volte non è un pregio ma un difetto. Mi abituo alla mia meschinità, al mio peccato, alla mia mediocrità, alla mia incapacità di amare. Mi installo. Ma l’acqua che non scorre diventa uno stagno, e può imputridirsi. L’essere in movimento, in cammino, è l’opzione migliore.
La stasi e il movimento. Anche la disciplina inventata da Freud, nei primi del 900, sottolinea l’importanza del movimento: psicodinamica, anche così si chiama la psicologia del profondo, la psicoanalisi.
Preferiamo la pianura noi essere umani ma, ad alcuni di noi, dopo un poco comincia a stare stretta. Sentiamo la necessità della salita, dell’ascesa, o di andare per mare. Vengono in mente le parole del Moby Dick.
O quelle del Richiamo della foresta.
Dopo un tempo speso a passarsela bene l’artiglio gelato dell’inquietudine arriva a ghermirci alle spalle. Orsù si parte.
Occorre tenere acceso il fuoco, la speranza, come fa il bambino, su suggerimento del padre, nel romanzo di Cormac McCarthy intitolato “La strada” (2007, Giulio Einaudi editore). Un romanzo cupo, duro, nel quale un uomo e un bambino, padre e figlio, sopravvissuti ad un’apocalisse, si mettono in viaggio. Il mondo ridotto in cenere, le notti lunghe, buie e fredde. Di “un freddo che spaccava le pietre”. Bande di predoni battevano le strade, disposti a tutto pur di sopravvivere.
Ce la caveremo, vero, papà?
Sì. Ce la caveremo.
E non ci succederà niente di male.
Esatto.
Perché noi portiamo il fuoco.
Sì. Perché noi portiamo il fuoco.
Luogo di fatica, la montagna, una fatica che non si può evitare, non c’è un rimedio che si può comprare, si può solo patire. Non serve avere il portafoglio pieno, meglio lo zaino carico di vettovaglie ed un fiato allenato. Fiato, respiro, come risuonano strane queste parole in tempi di Covid.
Dolore fisico, a volte dolore mentale, quello del fallimento per esempio.
Luogo concreto dunque, ma luogo soprattutto psichico. Paesaggio interiore.
In montagna ci si conosce, ci si comprende, si scopre, nella sofferenza della fatica, di che stoffa siamo fatti. Come nella tempesta fa il nocchiere.
La montagna è terapia. La natura, lo sappiamo da sempre, è un potente fattore curativo.
In montagna si tesse l’elogio dell’insicurezza, della precarietà. Parole che non amiamo, ma che rappresentano bene la condizione di ogni essere umano. Ci ricordano la nostra natura di creature, non di Creatore. Sono un monito all’edificazione della nostra Torre di Babele, il monumento a noi stessi, che parla di noi, e mostra agli altri quanto siamo bravi. Che bravo alpinista che sono, che bravo psicoterapeuta. “Vanità delle vanità, dice Qoèlet, vanità delle vanità, tutto è vanità. Quale utilità ricava l’uomo da tutto l’affanno per cui fatica sotto il sole?” (Qoèlet, 1, 2 – 3)
I rimandi, come si può vedere, ad un camminare in montagna sono simili a quelli che si possono formulare quando si compie l’altro viaggio, quello analitico. Anche questo costa fatica, passione, introspezione.
L’uno e l’altro consentono di rispondere alla domanda fatta da Dio ad Adamo, nel Paradiso Terrestre: “Dove sei?” (Genesi 3, 9)
Come Giona, che dopo tre giorni uscì dalla balena,
Ed ora ….. buona visione.