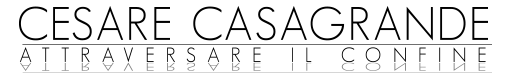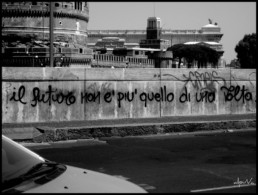Prefazione al libro sul Gran Sasso
Quello che avete tra le mani è un libro denso di immagini, pertanto non serviranno molte parole per introdurlo. Basterà lasciarsi andare, rinunciando al controllo, alla unilateralità della coscienza, all’arroganza egoica, per fare un’esperienza, stimolati dalla visione fotografica.
Dirò, pertanto, soltanto alcune cose.
Vorrei innanzitutto ringraziare Vincenzo che, con leggerezza e soavità, ci ha condotto lungo questo percorso. Un uomo che, se volessimo scolpirlo con l’accetta, potremmo definirlo cristiano, scout, medico. Un medico del soma, ma anche dell’anima, che sa prendersi cura. Questo libro, scritto per i tanti compagni di avventura che con lui hanno condiviso la sua vita lavorativa, lo testimonia.
Partirei da una frase, tratta dalla Seconda lettera ai Tessalonicesi:
E ora sapete ciò che impedisce la sua manifestazione, che avverrà nella sua ora. Il mistero dell’iniquità è già in atto, ma è necessario che sia tolto di mezzo chi finora lo trattiene. (2, 6 – 7).
San Paolo attribuisce il ritardo della parusia, della seconda venuta del Signore nostro Gesù Cristo, a qualcosa o qualcuno che “trattiene”, il katechon. Una forza o una persona che impedisce la manifestazione dell’Anticristo, lo trattiene, lo contiene, e che dovrà togliersi o esser tolta di mezzo, affinché l’Anticristo si disveli pienamente, prima del giorno del Signore. Una identità misteriosa la cui missione, dunque, è porre un argine alla devastazione morale rappresentata dall’insorgere dell’apostasia.
Nelle parole di Massimo Cacciari:
La fine è decisa. Non c’è novitas ancora da scoprire. Ma occorre sopportare con la fermezza del martire l’ultimo assalto dell’antico Drago. E’ la prova che il Signore impone prima della sua vittoria. Tuttavia, appunto, un’altra potenza sembra operare nello spasmo di questo tempo ultimo, sulla cui durata è vano congetturare – una potenza che raffrena l’apocalisse, il disvelarsi perfetto dell’Empio. Ma quando colui che la incarna sarà tolto di mezzo, allora, nulla restando fra l’Avversario e il Signore Gesù, verrà finalmente quest’ultimo a condannare tutti coloro che non hanno creduto alla sua verità. La parola greca è to katechon. (Il potere che frena, di Massimo Cacciari, 2013 Adelphi Edizioni, pag. 13)
Perché il katechon impedisce che l’Anticristo si mostri e, così facendo, ritarda la venuta del Cristo?
Forse Dio, nella Sua infinita misericordia, ci concede altro tempo: un tempo per convertirci, per fare pace con la nostra storia, per tornare a Lui. Noi, che amiamo passarcela bene, non avere problemi, noi che spesso siamo gente di pianura, non amiamo le salite. Quasi non ce la facesse a chiudere definitivamente la saracinesca, per aprire lo scenario del Giudizio Universale.
Detto questo vorrei fare un paragone ardito e provare a cogliere prima nel percorso psicoanalitico, e poi nei sentieri che portano in montagna, nella Natura, nella Wilderness, un katechon, una forza che trattiene e frena l’allontanarsi dell’uomo da se stesso.
La psicoanalisi, potremmo pensarla come una forma di resistenza. Resistenza a cosa? A chi? Resistenza alla superficialità, alla mentalità oggi dominante, a ciò che ci tiene schiavi, al nostro lato oscuro, alla parte patologica.
Questo, forse, vale anche per la montagna, per il Gran Sasso.
In un mondo che cambia troppo rapidamente, in una società capitalistica dove tutto si consuma e si getta via, nulla si ripara o si rammenda, dove si parla troppo, spesso del nulla, la montagna ci dà una testimonianza muta.
E’ lì, ci aspetta, in silenzio.
Fedele, non traditrice, leale, sincera. Perfino benevola, se la trattiamo con rispetto e accettiamo i limiti che essa ci pone. Se non ci perdiamo nel suo contrario, il dionisiaco, l’orgiastica assenza di limiti.
In una società che si sgretola, nella quale gli esseri umani non sono più un fine ma un mezzo, la montagna rimane impavida, tetragona, ferma su se stessa, serena, severa. Almeno fino a quando il cambiamento climatico non la colpirà troppo duramente.
Costituisce un “Altrove”, con tante sfaccettature. Luogo di ristoro, luogo con il quale cimentarsi, luogo di solitudine nutriente, luogo di preghiera, luogo ascendente, verticale, quasi tendente al trascendente. Soglia tra il conosciuto della propria tana e lo sconosciuto che ne sta fuori.
Luogo che richiede l’accesso alla propria “capacità negativa”, per rimanere nella scivolosità e precarietà del perdersi, del ghiaccio sotto i piedi, del vuoto, dell’abisso. E’ l’attitudine del funambolo, o del trapezista che per un momento, lasciato un trapezio e non avendo ancora preso l’altro, svetta nel vuoto.
E sappiamo che l’abisso chiama l’abisso. Recita il Salmo 64, versetto 7: “un baratro è l’uomo e il suo cuore un abisso.”
La natura è anche il luogo dei “sentieri interrotti”, dei quali parla Heidegger. Ma spesso un perdersi è già un ritrovarsi. Spesso occorre smarrirsi, disorientarsi, per trovare un nuovo orientamento, per cogliere dov’è il nuovo, l’oriente. “Strappare lungo i bordi”, di Zerocalcare, è il titolo di una serie tv di successo, su Netflix. Si parla, già nel titolo, dei percorsi obbligati, e ci danno, questi bordi, una illusione di sicurezza. Il contrario dei sentieri interrotti che tanto piacevano ad Heidegger, che lo portavano a perdersi nella Foresta Nera. Esperienza da lui descritta come altamente emozionante e densa.
L’uomo si abitua facilmente a tutto, e questo a volte non è un pregio ma un difetto. Mi abituo alla mia meschinità, al mio peccato, alla mia mediocrità, alla mia incapacità di amare. Mi installo. Ma l’acqua che non scorre diventa uno stagno, e può imputridirsi. L’essere in movimento, in cammino, è l’opzione migliore.
La stasi e il movimento. Anche la disciplina inventata da Freud, nei primi del 900, sottolinea l’importanza del movimento: psicodinamica, anche così si chiama la psicologia del profondo, la psicoanalisi.
Preferiamo la pianura noi essere umani ma, ad alcuni di noi, dopo un poco comincia a stare stretta. Sentiamo la necessità della salita, dell’ascesa, o di andare per mare. Vengono in mente le parole del Moby Dick.
O quelle del Richiamo della foresta.
Dopo un tempo speso a passarsela bene l’artiglio gelato dell’inquietudine arriva a ghermirci alle spalle. Orsù si parte.
Occorre tenere acceso il fuoco, la speranza, come fa il bambino, su suggerimento del padre, nel romanzo di Cormac McCarthy intitolato “La strada” (2007, Giulio Einaudi editore). Un romanzo cupo, duro, nel quale un uomo e un bambino, padre e figlio, sopravvissuti ad un’apocalisse, si mettono in viaggio. Il mondo ridotto in cenere, le notti lunghe, buie e fredde. Di “un freddo che spaccava le pietre”. Bande di predoni battevano le strade, disposti a tutto pur di sopravvivere.
Ce la caveremo, vero, papà?
Sì. Ce la caveremo.
E non ci succederà niente di male.
Esatto.
Perché noi portiamo il fuoco.
Sì. Perché noi portiamo il fuoco.
Luogo di fatica, la montagna, una fatica che non si può evitare, non c’è un rimedio che si può comprare, si può solo patire. Non serve avere il portafoglio pieno, meglio lo zaino carico di vettovaglie ed un fiato allenato. Fiato, respiro, come risuonano strane queste parole in tempi di Covid.
Dolore fisico, a volte dolore mentale, quello del fallimento per esempio.
Luogo concreto dunque, ma luogo soprattutto psichico. Paesaggio interiore.
In montagna ci si conosce, ci si comprende, si scopre, nella sofferenza della fatica, di che stoffa siamo fatti. Come nella tempesta fa il nocchiere.
La montagna è terapia. La natura, lo sappiamo da sempre, è un potente fattore curativo.
In montagna si tesse l’elogio dell’insicurezza, della precarietà. Parole che non amiamo, ma che rappresentano bene la condizione di ogni essere umano. Ci ricordano la nostra natura di creature, non di Creatore. Sono un monito all’edificazione della nostra Torre di Babele, il monumento a noi stessi, che parla di noi, e mostra agli altri quanto siamo bravi. Che bravo alpinista che sono, che bravo psicoterapeuta. “Vanità delle vanità, dice Qoèlet, vanità delle vanità, tutto è vanità. Quale utilità ricava l’uomo da tutto l’affanno per cui fatica sotto il sole?” (Qoèlet, 1, 2 – 3)
I rimandi, come si può vedere, ad un camminare in montagna sono simili a quelli che si possono formulare quando si compie l’altro viaggio, quello analitico. Anche questo costa fatica, passione, introspezione.
L’uno e l’altro consentono di rispondere alla domanda fatta da Dio ad Adamo, nel Paradiso Terrestre: “Dove sei?” (Genesi 3, 9)
Come Giona, che dopo tre giorni uscì dalla balena,
Ed ora ….. buona visione.
Avamposti dell'Anima
"Il deserto cresce", scriveva Nietzsche nello Zarathustra.
Cosa intendo dire, prendendo in prestito questa celebre frase?
Lo vedremo.
Intanto voglio suggerire l'importanza di creare un avamposto. Lo chiamerò Nantucket, che nel Moby Dick di Melville, è l'ultimo avamposto degli uomini prima dell'incontro con il Leviatano. Chi è il Leviatano oggi? Come affrontarlo? Come fermarlo?
Massimo Cacciari, nel suo saggio "Il potere che frena", illustrò con chiarezza il concetto cristiano di un qualcosa o qualcuno che frena (to katechon) l'arrivo del Maligno. La Natura, la bellezza, la poesia, la spiritualità, possono giocare un ruolo? Chi è il Maligno?
Vorrei riflettere su questioni apparentemente slegate: il monopattino, il telefonino e i social, google, il telecomando, la serranda elettrica, la casa domotica, Siri l'assistente dell'IPhone, l'intelligenza artificiale, l'asciugatrice, Just Eat, la pornografia, le droghe, l'alcol, le slide senza narrazione, Amazon, google traduttore, Wikipedia, le interrogazioni programmate, le interrogazioni dal posto, i BES (Bisogni Educativi Speciali), le microcar.
Qual è la condizione giovanile oggi? I giovani rappresentano l'Oriente, sono portatori del nuovo, di quell'anice stellato che i mercanti conducevano da terre lontane. Lo sono ancora, oggi?
Purtroppo molti sono affetti da una malattia terribile, prigionieri di quello che i monaci chiamavano il "demone meridiano": stiamo parlando dell'accidia e delle sue tante teste. Un'accidia, sostiene Francesco Borgonovo (Aretè, Liberilibri), che non è pigrizia ma spossamento, rinuncia, mancanza di volontà, perdita di forza e iniziativa, torpore.
Tutto ciò che favorisce una vita comoda, prima abbiamo fatto un elenco approssimato per difetto, toglie forza, virilità, che in questa accezione è una caratteristica tanto maschile quanto femminile. Le teste (le tante teste dell'accidia, NdR) invece si chiamano depressione, malinconia, fragilità, pessimismo, nichilismo, disorientamento, asessualità, calo del testosterone, incapacità di decidere, dipendenze, insonnia, disturbi alimentari, noia, caos, accelerazione, ADHD (Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività), intolleranza alla frustrazione.
Un discorso a parte merita la mancanza del desiderio, è questa "L'epoca delle passioni tristi", suggerivano Miguel Benasayag e Gérard Schmit. Non c'è più una cattedrale da costruire, la pietra d'angolo da posizionare. Il cielo è chiuso, la speranza svanita. Tutto questo genera quella che è, forse, la patologia più nominata del nostro tempo, e la testa più inquietante da affrontare: l'ansia e le sue sorelle, ossia l'angoscia e il dominio del Dio Pan, l'attacco di panico. In compagnia poi degli altri disturbi legati alla paura, come il DOC (Disturbo Ossessivo Compulsivo) e le fobie.
Una generazione del tutto tremolante.
Un best seller del 2024 è stato il libro di Jonathan Haidt, psicologo sociale americano, eloquentemente intitolato "La generazione ansiosa", edito da Rizzoli. Secondo lui, l'accesso a internet e ai social ha fatto si che questa epidemia scoppiasse.
Il filosofo Byung Chul Han, già diversi anni fa, definiva l'Occidente come la "società della stanchezza". Il religioso barnabita Padre Antonio Gentili sostiene, giustamente, che ci siamo "infrolliti". Lo psicanalista junghiano Claudio Risé suggerisce, invece, di ritrovare il nostro lato selvatico ("Il maschio selvatico"). Baumann, con un'espressione felice, parlava di "società liquida". Ma oggi, ad essere liquidi, sono soprattutto i giovani. Il liquido, è evidente, assume la forma del contenitore nel quale è contenuto. Oggi i contenitori, purtroppo, sono gli influencers, le visualizzazioni su tiktok.
Per Nietzsche il nichilismo è la mancanza di un fine, manca la risposta al perché, tutto è insensato. Umberto Galimberti l'ha definito "l'ospite inquietante".
Non ci sono più motivazioni, ma solo pulsioni. Come novelli Bartleby ("Bartleby lo scrivano"), lo scrivano protagonista del romanzo di Herman Melville, ripetono "preferirei di no". Dicono no alla vita e finiscono, come il protagonista del romanzo, in prigione, prigionieri di una immobilità senza senso. Non sapendo gestire la pressione, vanno in crisi di fronte alle difficoltà e preferiscono ritirarsi, rinunciano alle sfide invece di provare a vincerle. Oggi si parla spesso dei Hikikomori, ma anche senza arrivare a tanto, di "preferisco di no", purtroppo, ne vengono detti molti.
Il deserto cresce, dicevamo all'inizio.
Vivono in una bolla artificiale, nutriti, anzi super alimentati da cibo spazzatura, accuditi, mantenuti in un brodo tiepido. Viene in mente una scena inquietante del film Matrix, nella quale gli essere umani pensano di vivere, mentre in realtà sono immobili all'interno di un bozzolo, di una capsula, di una realtà illusoria. Matrix, lo ricordiamo, è una potentissima tecnologia di neuro-simulazione che costruisce una realtà fittizia nella mente delle persone. Credono di vivere, in realtà sono immobili nel loro sarcofago.
Il film, profetico, è del 1999. Il mondo, fuori dalle nostre case, non è tutto rose e fiori. Mi ha colpito una frase detta da uno dei protagonisti della serie Netflix "The Gentlemen", ideata da Guy Ritchie. La frase, cito a memoria, recita così: "Loro (dice riferendosi agli aristocratici inglesi, NdR. E per estensione possiamo includervi tanti nostri giovani) vivono nello Zoo. Noi (intendendo noi criminali, NdR) nella Giungla".
Prima o poi bisogna uscire dalla grotta, dall'arcinota zona di comfort, pena il non vivere. E fuori, nella giungla, fa freddo, si ha fame, paura, irrompe il "perturbante", il "sinistro" capace di sconvolgere l'ordinarietà delle cose (Freud parlava di Unheimlich). Michele Serra, in un suo fortunato romanzo, definiva questi giovani "gli sdraiati". Attenzione, parliamo di gioventù, ma questi fenomeni sconfinano e riguardano anche molti adulti.
Non si studiano più le tabelline, c'è la calcolatrice sul telefonino, non si imparano più a memoria le poesie. Questo ha determinato un calo della capacità di memorizzare, di prestare attenzione. Ci si informa sui social, ed ecco che lo spirito critico viene sostituito dall'algoritmo, dall'intelligenza artificiale.
Non ci si parla, ma ci si scrive e si utilizzano in abbondanza gli emoticon. Pertanto il linguaggio non è più fluente. Si fatica a scrivere un tema. Non parliamo poi della lettura. I libri sono banditi, sono oggetti del tutto obsoleti. Ecco allora che la comprensione del testo precipita, si approssima allo zero. Se abbiamo uno strumento che fatica al nostro posto, noi perdiamo la capacità di fare quel lavoro. Chi di noi saprebbe oggi destreggiarsi con Tuttocittà? Il navigatore satellitare ha fatto sì che la capacità di orientarci e di leggere una cartina, si atrofizzassero. Lo stress fa male, ma anche la totale mancanza di stress non va bene. Zoo o giungla?
Gli antidoti a tutto questo, purtroppo, non sono del tutto apprezzati dalla cultura dominante. Hanno nomi che risultano ruvidi ai più, quali fatica, sofferenza, regole, ordine, rispetto di se e degli altri, sacrificio, fame, riscoperta del lato selvatico, competizione, vita all'aria aperta, arti marziali, scoutismo, sforzo, sano superamento del limite senza sconfinare nel dionisiaco.
In fondo "E' solo dolore", dice Isaac, il protagonista maschile della serie Netflix "American Primeval", a Preston Mote, il bambino ferito dallo zoccolo del cavallo, quando gli ricompone e stecca la frattura della gamba. Non dobbiamo allontanare il dolore, sia esso fisico che psichico, ma attraversarlo.
Le persone nate con menomazioni, come per esempio i focomelici, hanno un tasso di suicidio più basso delle persone sane. Come mai? Imparano prestissimo, non possono non farlo, a spostare l'attenzione da ciò che non hanno a ciò che hanno. Questo ha a che fare con la felicità. Avevo paura dell'acqua ma, fortunatamente, mia madre voleva che imparassi a nuotare. L'insegnante mi buttò dove non toccavo. Annaspai, ebbi paura, ma poi iniziai a nuotare. Oggi sono un amante dell'acqua ed un buon nuotatore. Non ricordo più chi fosse quel maestro, sicuramente oggi non sarebbe possibile un metodo di codesto tipo. Tutti ateniesi e nessuno spartano. Ma ricordiamoci che, narra la Storia, o forse la leggenda, gli spartani ai loro figli regalavano una barca, gli ateniesi una casa, un campo. Marinaio o agricoltore? Cosa vogliamo essere?
Ero lasciato spesso solo, da piccolo. Per vincere la noia creavo mondi, inventavo storie, fui costretto a diventare creativo, a rifugiarmi nei tanti libri di avventura di Emilio Salgari, che divoravo. Tutto questo mi ha aiutato e mi aiuta ancora, anche nel mio lavoro di psicanalista, perché facilita le associazioni, le amplificazioni, l'immaginazione, la costruzione di altri scenari. Oggi purtroppo si ha il terrore di annoiarsi, e si riempie ogni interstizio. Non ci sono più vuoti. Semmai si scrolla il telefonino o si guarda una serie. Se non ho accesso a tutto questo, ma ho un foglio ed una penna, dopo poco, probabilmente, comincio a scrivere, o a disegnare. Se ciò non accade, se non consento alla noia di operare, a lungo andare, il QI inizia a calare, la capacità di prestare attenzione si assottiglia. Le sinapsi non si creano, la plasticità del cervello si deteriora.
Così come cala oggi, lo dicono le ricerche, il testosterone. Probabilmente per una serie di fattori: poco esercizio fisico, ridotta vita all'aria aperta, paura delle relazioni, sempre più sostituite dall'uso della pornografia, vero killer della virilità e del desiderio dell'Altro reale. Come rabdomanti alla ricerca dell'acqua, oggi si utilizza, al posto della bacchetta di legno biforcuta a forma di Y, il telefonino. Alla ricerca di non si sa quale elemento vitale. Forse acqua virtuale di una vita virtuale, che non disseta, non ha sapore.
Tutto questo non significa che dobbiamo rifiutare la Tecnica, che in sé è una cosa buona, ma alle distorsioni, all'oltre misura. Non vorrei sembrare troppo pessimista, ma non ho molti elementi che mi convincono del contrario. Purtuttavia non possiamo non sperare in un nuovo Rinascimento.
L'Abruzzo evoca transumanza, pastori, bellezza, mare e terra. La montagna come nuovo avamposto? Forse questa è una visione romantica, troppo romantica. Certo è che abbiamo bisogno di luoghi con l'Anima e di educatori capaci di trascinare questa umanità fuori dalle sabbie mobili.
Occorrono genitori, uomini di fede, politici, che abbiano preso la "pillola rossa" della consapevolezza (Matrix docet), che si rimbocchino le maniche e si dedicano a questa umanità ferita.
In termini junghiani, abbiamo bisogno dell'integrazione degli opposti. La condizione giovanile, dicevamo, è dominata dal demone meridiano, che toglie forza, libido intesa come energia vitale, desiderio, illanguidisce. Si entra in una sorta di torpore immobile, senza scopo e senza senso. In qualche modo il tempo cessa di essere una retta e diventa ciclico. Tutto è ripetitivo, le giornate uguali le une alle altre. Una specie di steppa indifferenziata, che ricorda da vicino la follia. Gli esseri umani ragionano per polarità: bianco e nero, bene e male, altezza e profondità, cristiano e pagano, primitivo e civilizzato, amore e odio, calma e agitazione, ragione e follia.
Tempo pieno e tempo vuoto, tempo lavorativo e tempo di riposo. Non amano la steppa, dove c'è un'unica polarità. Il demone meridiano rompe la categoria degli opposti, e se gli opposti spariscono ci si perde, ci si spalma in orizzontale, si perde lucidità, consapevolezza. Occorre allora prendere gli scarponi e, come Ismaele prende il mare (Moby Dick, di Herman Melville, NdR), prendere la via del Gran Sasso. Costa fatica, è vero, ma grande sarà la ricompensa. Questo gesto va compiuto concretamente, ma soprattutto simbolicamente. Il Gran Sasso da affrontare, come il Leviatano, come il Moby Dick per il capitano Achab, è ciò che ci schiaccia nella vita, che ci terrorizza, siano essi elementi esterni che demoni interni.
Per far questo occorre coraggio, che non è virtù donata. La paura, si sa, si vince con un atto di coraggio. Di nuovo serve una famiglia che trasmetta questa capacità, un padre con la schiena dritta, che ci accompagni lungo i sentieri in salita, stringendo i denti con noi, una comunità, intellettuali coraggiosi, uomini ispirati da Dio, degli educatori e dei poeti.
Occorre il coraggio di Sam che, pur proclamando tremante queste parole: "Se faccio ancora un passo, non sono mai andato così lontano dalla contea, padron Frodo" (citazione a memoria, Il Signore degli anelli, di J.R.R. Tolkien, NdR), non abbandonò Frodo Baggins nella sua epica impresa.
Immobile e senza coraggio, mancherai al compito più importante della tua vita, quello che il fondatore della Psicologia Analitica, Carl Gustav Jung, chiamava il processo individuativo: "diventa ciò che sei". Se sei una ghianda, devi diventare una quercia, non un castagno, o l'infelicità ti accompagnerà sempre.
Occorre però la pillola rossa, il coraggio, la "fortezza" in termini cristiani.
Farei nostra, per concludere, la poesia del poeta-sociologo Danilo Dolci, che così recita:
"C’è chi insegna
guidando gli altri come cavalli
passo per passo:
forse c’è chi si sente soddisfatto
così guidato.
C’è chi insegna lodando
quanto trova di buono e divertendo:
c’è pure chi si sente soddisfatto
essendo incoraggiato.
C’è pure chi educa, senza nascondere
l’assurdo ch’è nel mondo, aperto ad ogni
sviluppo ma cercando
d’essere franco all’altro come a sé,
sognando gli altri come ora non sono:
ciascuno cresce solo se sognato."
Guardiamo al padre, alla cima del monte, alla luna, a Dio. Forse ce la faremo.
"sognando gli altri come ora non sono:
ciascuno cresce solo se sognato."
Cesare Casagrande
psicologo, psicoterapeuta, psicoanalista junghiano
Sul Padre. Tre
Vorrei provare a dipingere alcuni modi di essere Padre, facendomi aiutare da quel capolavoro letterario che è la Sacra Bibbia.
Partiamo dall’inizio.
Dio disse: ”Sia la luce!”. E la luce fu. (Genesi 1, 3)
E’ questo uno dei primi versetti del Libro dei Libri. Il Verbo, il Logos, lo Spirito di Dio che aleggiava sulle acque, il Principio Paterno, pone in essere il primo atto di differenziazione. Attività squisitamente paterna quella della separazione – differenziazione, alla quale si deve la nascita della coscienza. Separazione, frustrazione, processo simbolico, accesso alla dimensione adulta.
Il Signore disse ad Abram: “Vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò.” (Genesi 12, 1)
Esci dall’utero, dalla tana nella quale ti trovi, inizia il tuo percorso trasformativo. Un Padre che chiede al figlio di uscire dalla casa dei Padri, dalla propria Patria, per farsi straniero nel mondo.
così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato; qui Abramo costruì l’altare, collocò la legna, legò il figlio Isacco e lo depose sull’altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. (Genesi 22, 9s)
Il suo unico figlio, avuto in vecchiaia da una moglie sterile. Abramo ha ascoltato il Padre e ha ubbidito al Suo “progetto”. Quanti padri riuscirebbero a fare questo? E che tipo di insegnamento avrà tratto Isacco? C’è un canto molto bello, in uso presso le Comunità Neocatecumenali, che s’intitola Akedà e vede l’episodio con gli occhi del figlio. Così recita:
Era ancora notte quando Abramo si disponeva a sacrificare suo figlio; si guardavano i due negli occhi, quando dice Isacco: “Akedà, akedà, akedà, akedà. Legami, legami forte, padre mio, che io non resista! Legami, legami forte, padre mio, non sia che per paura io resista, e non sia valido il tuo sacrificio, e tutti e due siamo rifiutati!”
Che rapporto, stupendo e terribile allo stesso tempo, tra questo Padre e questo figlio. Un figlio che accetta, fidando nel Padre, di essere immolato, senza ribellarsi.
Isacco prediligeva Esaù, perchè la cacciagione era di suo gusto, mentre Rebecca prediligeva Giacobbe. (Genesi 25, 28)
I figli non sono tutti uguali, né lo è la nostra predisposizione nei loro confronti, è nell’ordine delle cose.
Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell’aurora. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all’articolazione del femore e l’articolazione del femore di Giacobbe si slogò, mentre continuava a lottare con lui. Quegli disse: “Lasciami andare, perché è spuntata l’aurora”. Giacobbe rispose: “Non ti lascerò, se non mi avrai benedetto!”. Gli domandò: “Come ti chiami?”. Rispose: “Giacobbe”. Riprese: “Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto!” (Genesi 32, 25-29)
Questa scena può diventare l’immagine di tutti i combattimenti: che siano spirituali o che non lo siano, con l’alterità, con l’Altro, con il Maestro, con il proprio Padre. Immagine quindi di ogni incontro significativo e, come tale, trasformativo, capace di cambiare la propria vita. Immagine, pertanto, anche dell’incontro analitico. Giacobbe porterà i segni del combattimento: rimarrà zoppo ed il suo nome diventerà Israele. Nella tradizione ebraica, il cambiamento del nome corrisponde al cambiamento profondo di se stessi.
Incontriamo ora un’altra figura biblica, quella di Giobbe, che ci dà la possibilità di parlare dei limiti.
Il Signore rispose a Giobbe di mezzo al turbine: “Chi ha chiuso tra due porte il mare, quando erompeva uscendo dal seno materno, quando lo circondavo di nubi per veste e per fasce di caligine folta? Poi gli ho fissato un limite e gli ho messo chiavistello e porte e ho detto: Fin qui giungerai e non oltre e qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue onde.” (Giobbe 38, 1.8-11)
Riconosciti creatura, non Creatore, ricordati che i limiti è il Padre che li fissa. Questo è, credo, il senso dei versetti appena citati.
Ed il non ancora Papa, Cardinale Joseph Ratzinger, a proposito del Libro di Giobbe:
La risposta di Dio a Giobbe non serve a spiegare, bensì soltanto a correggere la nostra illusione di poter giudicare tutto e di poter sentenziare su tutto, e a ricordarci dei nostri limiti. Essa esorta i fedeli a credere al mistero divino nella sua incomprensibilità.
Un discorso fuori moda questo, che condanna il relativismo e che c’invita a lasciare l’onnipotenza infantile, per entrare nel mondo degli adulti.
A proposito di fanciulli senza limiti, come non ricordare Icaro. A costui il padre, Dedalo, raccomanda di non volare troppo in alto, né troppo in basso, con quelle ali costruite con penne e cera. Se voli troppo in basso, le penne potrebbero essere inumidite dal mare; se voli troppo in alto il sole potrebbe scioglierle. In altre parole: non diventare preda delle bassezze, e non permettere alle fantasie onnipotenti di crescere a dismisura. Rimarranno del figlio solo delle penne sparse, galleggianti sul mare.
Sempre a proposito di limiti, regole, norme:
Dio allora pronunciò tutte queste parole:
“Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d’Egitto, dalla condizione di schiavitù: non avrai altri dei di fronte a me.” (Esodo 20, 1-3)
E’ l’inizio del decalogo: Mosè scese dal monte portando le Tavole della Legge. E’ interessante notare che, i Padri della Chiesa, parlano anche di Tavole della Vita: segui questi comandamenti, ed avrai la Vita Eterna. Non solo, avrai anche una “good life”, direbbe Carl Rogers, qui e ora.
I limiti, i confini, lo steccato, il “questo non si puo’ fare”, servono ai figli per non sbandare, per avere un riferimento, magari contro il quale lottare. Altrimenti perdono la bussola e vagano intorpiditi, prede dei vari Lucignolo e Mangiafuoco.
C’è poi il momento della prova:
Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in questi quarant’anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l’uomo non vive soltanto di pane, ma che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. (Deuteronomio 8, 2s)
Non si giunge alla Terra Promessa se, prima, non si attraversa il deserto. Per arrivare all’età adulta, occorre sperimentare che la terra è anche arida ed arsa, senz’acqua, che spesso si è soli. E’ vero, il Padre deve vigilare e sostenere nel momento del bisogno, forse è questo il significato della manna, ma deve farlo da lontano, di nascosto, o la maturazione, se non si consente l’esperienza, non avverrà.
Se un uomo avrà un figlio testardo e ribelle che non obbedisce alla voce né di suo padre né di sua madre e, benché l’abbiano castigato, non dà loro retta, suo padre e sua madre lo prenderanno e lo condurranno dagli anziani della città, alla porta del luogo dove abita” (Deuteronomio 21, 18s)
Il consiglio degli anziani appartiene all’antichità, così come la famiglia patriarcale. Molti nuclei familiari, oggi, sono composti da madre e figlio. Chi esercita in questi casi l’autorità? Chi può far sentire un peso analogo a quello del consiglio degli anziani?
Ma il giusto atteggiamento, del Padre verso i figli, è anche il seguente:
Egli lo trovò in terra deserta, in una landa di ululati solitari. Lo circondò, lo allevò, lo custodì come pupilla del suo occhio. Come un’aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati, egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali. (Deuteronomio 32, 10s)
E la tenerezza si coglie anche nel brano, Osea 11, 1-11, che parla dell’amore del Padre per il suo popolo, per i suoi figli. Di seguito riporto un pezzettino del canto, in uso presso le Comunità Neocatecumenali, tratto da questo passo biblico:
Quando Israele era un bimbo io l’amai e dall’Egitto come un figlio lo chiamai, ma più lo chiamavo, più si allontanava da me. E non capiva che avevo cura di lui: Israel, Israel. Ad Efraim io insegnavo a camminare, li conducevo con legami di bontà, ero per loro come chi porta un bimbo alle guance.
L’Esperienza e la Sapienza sono difficili da trasmettere, non si trovano uditori. Appare quindi sensata l’esortazione che riportata è nei Proverbi:
Figlio mio, osserva il comando di tuo padre, non disprezzare l’insegnamento di tua madre. Fissali sempre nel tuo cuore, appendili al collo. Quando cammini ti guideranno, quando riposi veglieranno su di te, quando ti desti ti parleranno; poiché il comando è una lampada e l’insegnamento una luce e un sentiero di vita le correzioni della disciplina (Proverbi 6, 20-23)
Ci sono poi anche dei sorprendenti suggerimenti pratici:
Va dalla formica, o pigro, guarda le sue abitudini e diventa saggio. Essa non ha né capo né sorvegliante, né padrone, eppure d’estate si provvede il vitto, al tempo della mietitura accumula il cibo. Fino a quando, pigro, te ne starai a dormire? Quando ti scuoterai dal sonno? Un po’ dormire, un po’ sonnecchiare, un po’ incrociare le braccia per riposare e intanto giunge a te la miseria, come un vagabondo, e l’indigenza, come un mendicante. (Proverbi 6, 6-11)
Suggerimenti che si possono utilizzare, leggendoli ai figli piccoli.
E non far passare il tempo, sperando che le cose si aggiustino da sole:
Hai figli? Educali e sottomettili fin dalla giovinezza. (Siracide 7, 23)
E sull’educazione:
Un cavallo non domato diventa restio, un figlio lasciato a se stesso diventa sventato. Coccola il figlio ed egli ti incuterà spavento, scherza con lui, ti procurerà dispiaceri. Non concedergli libertà in gioventù, non prendere alla leggera i suoi difetti. Educa tuo figlio e prenditi cura di lui, così non dovrai affrontare la sua insolenza. (Siracide 29, 8s; 11; 13)
C’è poi la parabola dei talenti, che insegna a pretendere dai propri figli in maniera proporzionata alle loro capacità, non tenendo conto delle nostre proiezioni.
E quella del figliol prodigo, che ci mostra a prima vista un padre ingiusto e debole, che fa uccidere il vitello grasso per festeggiare il ritorno del figlio stolto. Costui, dopo aver dilapidato la sua eredità, pretesa in anticipo, finisce i suoi averi e non può far altro che tornare. Il maggiore, rimasto a casa a lavorare, mostra un volto inclemente: pretende giustizia. E l’accoglienza paterna, senza condizioni, sembra diseducativa nei confronti di chi torna, ma anche verso chi è rimasto. In realtà trattasi di amore incondizionato, di un padre che non chiede ma che dà, un padre che sa rigenerare i figli con la misericordia, quando questi si perdono nell’egoismo tipico dell’età. Al minore dà quell’accoglienza che fa crescere, al maggiore quella verità su di sé che fa, anch’essa, crescere. Ma si può essere compassionevoli soltanto se si considerano i figli come non propri. In questo caso non ci si sente traditi quando non corrispondono al nostro ideale.
Un po’ quello che dice Gibran, nei celeberrimi versi:
I vostri figli non sono figli vostri. Sono figli e figlie della sete che la vita ha di se stessa. .... Voi siete gli archi da cui i figli, come frecce vive, sono scoccati in avanti.
Poi c’è il:
E voi, padri, non inasprite i vostri figli, ma allevateli nell’educazione e nella disciplina del Signore. (Efesini 6, 4)
Senza mollare però. Vorrei ricordare le parole di Karol Wojtyla, riportate dalla Vinerba. Hanno a che fare con l’invito fatto al padre di non mollare la lotta, per il bene del figlio, e anche con l’invito al figlio di portare pazienza:
Non è forse vero che nella parola padre c’è posto anche per la paura? Non sarò mai solo bonaccia, ma anche tempesta. Né sarò solo dolcezza – vi mescolerò l’amaro. E per quanto mi sforzi di essere trasparente, sarò anche enigma. E non sempre troverai riposo; a volte per causa mia ti stancherai, figlia mia .... (Wojtyla K., Raggi di paternità)
Stiamo per terminare. Come non riflettere, allora, sul:
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? (Matteo 27, 46).
Epilogo amaro, stoltezza per i pagani, follia della Croce, per alcuni prova della non esistenza di Dio.
In realtà preferisco l’interpretazione artistica, data da Mel Gibson nel film The Passion. Una delle scene finali, prima della Resurrezione, mostra la Terra vista da Dio. Dio, Padre, assiste all’uccisione del Figlio, non la impedisce: la Storia deve compiersi, ma soffre con Lui. E piange. Si vede una lacrima precipitare dal cielo sulla terra e sconquassarla. Non interviene, permette la sofferenza del Cristo, ma non sta in un altrove, è lì, con Lui.
Ecco, forse è questo il comportamento da tenere con i figli. Non serve e non aiuta proteggerli sotto una campana di vetro, che li isola dalla vita. E’ giusto invece consentire alla sofferenza di attraversarli, permettergli di guardarla negli occhi. Soffrendo lì, accanto a loro, con loro. Un compito paterno, dunque, che non possiamo chiedere alla Madre, è sopra le sue forze, fin troppo contro la sua natura. Qui dovremmo spendere due parole sulle conseguenze dei divorzi, per la prole. Non dimentichiamoci che la Croce, la sofferenza, è necessaria per avviare il processo di trasformazione. Deve passare per la Croce, Cristo, se vuole arrivare alla rinascita, alla Risurrezione. Solo così può incontrare il proprio Selbst. E poi è uno sforzo senza senso quello di evitare il dolore, un po’ come quello di Sisifo, tanto la vecchiaia, la malattia e la morte hanno a che fare con ciascuno di noi.
Anche Jung ebbe a dire qualcosa del genere. In realtà parlava dei pazienti, ma le seguenti parole ben si adattano ai figli:
Se non avesse osato, se non avesse rischiato, la vita sarebbe forse stata privata di un’esperienza della massima importanza. Non rischiando mai la propria vita, non l’avrebbe mai conquistata.
Sul Padre. Due
Un writer, su un muro di Milano, ha scritto: “il futuro non é più quello di una volta”.
Ecco, noi, padri, dovremmo essere in grado di ridarglielo.
Potremmo essere d’accordo, ma se non ne siamo capaci, come fare?
Come diventare padri “sufficientemente buoni”?
In fondo non aspiriamo alla perfezione, ci accontentiamo della sufficienza.
Il cammino tuttavia è irto lo stesso. Sulla maglietta di mio figlio c’è scritto: “guida, non farti guidare”. Con queste premesse, indirizzarlo, non è un compito semplice.
Il discorso si complica, non di poco. Contano infatti i modelli incontrati, i nonni che hai avuto, il genitore che ti è toccato, il maestro che ti ha formato. Alla fine, dunque, è soprattutto una questione di come la propria personalità si è forgiata. Per questo, il compito di educare un figlio, comincia venti anni prima della sua nascita.
Ricordo ancora la mia maestra, la signorina Di Seri, che ci faceva cantare, rigorosamente sull’attenti, Fratelli d’Italia, o Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio, dei primi fanti il 24 maggio. Con lei sentivi che dietro le tue spalle c’era una Patria. In greco “pater” è padre, dalla radice “pa-”, possedere, nutrire, comandare; “patria” invece, o “patris gaia”, significa terra dei padri. Se mi comportavo male, durante la ricreazione, non esitava a tirarmi dietro le chiavi. Poi, quando a casa me ne lamentavo, prendevo anche il resto.
Anche Ettore, questo ci consola, qualche difficoltà la mostra. Inaspettatamente infatti, quest’uomo senza hybris, non arrogante, non riesce a chinarsi verso il bambino: ne è spaventato. Non entra in sintonia con lui, non sente l’infanzia dentro di sé, la troppa consuetudine con adulti guerrieri lo rende estraneo ad essa. Forse gli necessita il sorriso della moglie. Solo allora, infatti, si sfila l’elmo, lo pone a terra e abbraccia suo figlio, finalmente rassicurato. Per poi sollevarlo in alto, con le braccia, pregando.
Zeus e voi altri dei, rendete forte questo mio figlio. E che un giorno, vedendolo tornare dal campo di battaglia, qualcuno dica: “E’ molto più forte del padre.”
Un padre davvero generoso. Che ogni padre possa dire davanti al proprio figlio: “Egli deve crescere e io invece diminuire.” (Giovanni 3, 30)
Difficile, dicevamo, è il suo compito: se lo vede solo con le armi, continua Zoja, il figlio non lo riconosce; se non lo vede mai con le armi, non lo riconosce come padre.
Attenzione poi alla corazza, che protegge ma isola, a volte anche dal figlio. Ci ricorda ancora l’autore che, secondo un mito etimologico la corazza, dal latino “cor “ cuore, é ciò che protegge il cuore. Ma se non si smette mai l’armatura, succede che la si indossa anche di fronte a chi non ha nulla di aggressivo. E poi ci si abitua ad avere dei movimenti rigidi, limitati.
Ed i figli, oggi, come stanno?
Non molto bene, purtroppo.
Aumentano i giovani che si affidano solo al gruppo, sostituendo il padre con i capibanda. La cronaca è piena di episodi criminali da loro perpetrati. Pestaggio dei diversi (gay, tifosi di avversa fazione, appartenenti ad altri schieramenti politici o extracomunitari), episodi di bullismo, scippi, rapine, stupri di gruppo, lancio di sassi dai cavalcavia, omicidi, anche dei propri congiunti, accoltellamenti per futili motivi. Suicidi.
E anche quando non emergono fatti interessanti per la cronaca, un ospite inquietante siede alla loro tavola: il nichilismo, cita Umberto Galimberti.
Tanti Pinocchi abbandonano Geppetto, per inseguire Lucignolo. Non ascoltano nessun Grillo Parlante, qualora se ne incontrasse uno. Spesso, però, Geppetto non c’è. Non brilla solo la sua di assenza.
In una recente intervista radiofonica la Professoressa Anna Oliverio Ferraris, a proposito dello stupro di gruppo (sette minorenni ed un maggiorenne) ai danni di una sedicenne di Scampia, si chiedeva: “quali modelli forniamo a questi giovani?”
Il problema dilaga: è diventata una questione culturale, sociale e non più solo familiare.
Veline, letterine, tronisti, escort di successo, la fanno da padrone. Ad un evento culturale, come la Mostra del Cinema di Venezia, è stata accolta come una diva la signora D’Addario.
I ragazzi di oggi crescono in una sorta di stato selvatico, senza riferimenti se non quelli del gruppo, ed il più pazzo, spesso, viene eletto capo, leader. E’ lui che decide: questa sera si picchia, questa sera si corre in moto, questa sera si fa surf sul tetto di un treno, questa sera, giovani proci, si azzanna una povera Penelope.
I tempi sono cambiati, è vero: una volta i peggiori di noi riuscivano “solo” a far esplodere una miccetta, legata ad una povera lucertola.
L’85% dei detenuti maschi americani sono senza padre.
Educazione al controllo serve, oppure sono senza freni inibitori, fanno quello che vedono fare in tv, al reality o al telegiornale.
Una pubblicità di successo, era della Pirelli, recitava: “La potenza è nulla senza controllo.”
Inquietante anche un altro fenomeno, descritto da Zoja nel libro “La morte del prossimo”, quello dei “Hikikomori”. In inglese “neet”, che sta per “Not currently engaged in Employment, Education or training”, ossia “Al presente non impegnati in lavoro, studio o trocinio”. Sono, questi, dei giovani assenti dalla vita. Giovani che hanno abbandonato scuola, lavoro, vita sociale, da almeno sei mesi. Di solito primogeniti o figli unici di famiglie benestanti. Sono degli eremiti, chiusi a chiave nella loro stanza, svegli preferibilmente di notte e dormienti di giorno, ai quali i genitori lasciano il piatto con il cibo fuori la porta, collegati al resto del mondo solo da un computer. Mostrano difficoltà di ideazione, volontà azzerata, insufficiente progettualità, insicurezza, ansia. In genere il padre è silenzioso e assente.
A proposito dell’assenza, mi colpiva una frase riportata dall’autore a proposito di una sua paziente: “Il padre contadino era un tiranno, ma era un padre. Il padre operaio di oggi è un cretino seduto davanti alla tv.”
Sul Padre. Uno
Tema affascinante e complesso questo. Nessuno, purtroppo, insegna la difficile arte di essere genitore. Non c’è una scuola specifica, né un modello di riferimento. I nostri padri erano, spesso, dei padri assenti. Ciò malgrado non ci si può esimere da questo compito, non ci sono agenzie educative sostitutive. Si può solo contare sulle proprie forze e capacità, fare esperienza sulla propria pelle, soprattutto su quella del primogenito. La responsabilità é qualcosa da cui non ci si può dimettere.
Come sono i padri oggi?
Come dovrebbe essere un Padre?
E come non dovrebbe essere?
Luigi Zoja, nel libro “Il gesto di Ettore”, descrive assai bene la condizione attuale.
Trattasi spesso di padri silenziosi perché deboli, assenti, troppo occupati nella carriera. Dei breadwinner, dei cacciatori di reddito. Oppure padri-amici, quasi coetanei dei figli, padri/fratelli. Padri che delegano completamente, alla propria moglie, l’educazione della prole. Troviamo poi dei padri – fuchi, dediti all’alcool, perenni cacciatori di sesso. Regrediti quasi allo stato animale, tornati semplicemente ad essere “maschi”. Ostaggi del proprio istinto animale maschile, bramosi di una femmina, senza desiderio alcuno di avere un rapporto profondo con lei, rifiutando la paternità dei figli. O padri troppo femminilizzati, con la tracolla di Luis Vuitton, infradito e del tutto depilati. Assai diversi dal virile Ettore che porta un’armatura, aggressiva e difensiva, anche quando abbraccia il figlio. Dal capofamiglia, negli ultimi anni, si é andati verso il “co-parent”, ossia il padre che condivide i compiti della madre. Quando addirittura non si è passati ad una sorta di maternizzazione.
Dunque, il Padre con la P maiuscola, è oramai scomparso.
Mi viene in mente la storia di S., una giovane paziente venuta da me perché soffriva di sbandamenti. L’ennesima visita specialistica aveva escluso qualsiasi causa organica, lo psicologo era la sua ultima spiaggia. Non ci è voluto molto a capire che “sbandava” perché non aveva dei punti fermi nella sua vita, chiedeva regole, contenimento, opposizione, direzione, senso, tutto quello che un padre debole e permissivo non gli aveva mai fornito. Chiedeva un NO, un QUESTO NON LO PUOI FARE.
Il Padre dovrebbe, credo, insegnare al figlio ad essere nella società. Rimanere vicino alla prole nel bene e nell’amore, come fa la madre, ma anche nella forza.
Illuminante, al riguardo, è l’esperienza di Freud con suo padre. Mi riferisco all’episodio del marciapiede: “E tu, cos’hai fatto?” Con calma il padre rispose: “Sono sceso dal marciapiede e ho raccolto il berretto.” Freud ne rimase traumatizzato.
Con me sii buono, amami, sii giusto, ma con gli altri prima di tutto sii forte. Questo avrebbe voluto dire il giovane Sigmund al padre.
L’aneddoto è il seguente. In quel tempo le strade non esistevano. Quando pioveva, per evitare d’infangarsi, mettevano delle passerelle di legno, larghe tanto da far passare un uomo per volta. Il padre di Freud raccontò al giovane figlio che un giorno, trovandosi davanti un omone che non voleva cedere il passo, accadde che l’energumeno gli strappasse il cappello di testa gettandolo nel fango.
Ma anche Jung non era propriamente orgoglioso del proprio Padre, un pastore “tiepido” nella Fede, debole e per nulla autorevole.
Il figlio vuole un padre vincente, se poi vince con giustizia, nel bene e con amore, tanto meglio.
Il padre perdente, alcolizzato, tossicodipendente, disoccupato, come può adempiere con successo alla funzione genitoriale?
John Steinbeck, nel suo capolavoro “Furore”, sul viaggio dei Joad, è chiaro: per i padri l’insuccesso é comunque una colpa.
Questa è la fortuna della madre: sarà valutata solo come madre, per quello che fa con il figlio.
Il padre, invece, non è padre solo per quello che fa con il figlio, ma anche per quello che fa con la società, per come sta nella società, ci ricorda Zoja.
Un padre vincente, dunque, non un padre perfetto, che si staglia come un gigante, modello irraggiungibile per il figlio.
Il Padre dovrebbe, poi, costituire un contenitore, una sorta di parete che protegge, un bordo, un confine, capace d’impedire al figlio di “cadere all’infinito”.
Separare il figlio dalla madre, staccarlo dal seno per farlo crescere. Promuovere la differenziazione, usare la spada per rompere, dividere, aprire la strada all’individuazione.
Neumann ha ben illustrato la circolarità madre–figlio, dalla quale è necessario uscire, con l’immagine dell’Uroboro originario, il serpente che si mangia la coda. Nessuno sviluppo è possibile.
Occorre frustrare in maniera dosata, anche dando delle punizioni; una sorta di rimedio omeopatico. Curare il simile con il simile: piccole dosi di sofferenza, per fortificare la psiche in vista di sofferenze maggiori.
Essere colui che fa “attraversare il deserto” alla prole, certamente accompagnandola, ma non evitandogli le scottature. Non solo “manna” ma anche digiuno.
Essere autorevole, non autoritario. Troppo spesso, oggi, il padre manca dell’uno e dell’altro.
Essere non timoroso del dialogo, non stancarsi mai di parlare. Impedire che si rompa quel sottile filo comunicativo che lega alla propria prole.
Porre delle regole, alcune negoziabili, altre no.
Dare l’esempio, con la propria vita, e in questo modo insegnare senza comandare.
“Perdere” tempo con i figli. Sarebbe più comodo, la sera, lasciarli davanti alla tv, piuttosto che leggergli il libro delle favole. E’ più facile “comprarli”, che “conquistarli”, quindi gli si dà sempre più denaro e sempre meno tempo.
Essere capace di trasmettere progettualità, di rinviare il bisogno, far passare dal concreto al simbolico, favorire l’astrazione, insegnare loro a rinunciare al consumo immediato e divorante, scegliere l’essere, non l’avere.
Orientarli nella vita, aiutarli a scegliere, per poi sostenerli.
Cogliere ogni occasione per lodarli, “ogni” occasione.
E, naturalmente, accettarli ed amarli.
In ultima analisi, con loro, occorre forza e dolcezza. Adempiere la funzione guida ed instaurare un rapporto nutritivo, che promuova la specificità del figlio, che ne favorisca l’Individuazione.
Cesare Casagrande -
L'Islanda
C’era una volta un bambino solo, era sempre solo, orrendamente solo.
Vagava, incarnando l’archetipo del viandante.
Sempre in cerca, ovunque straniero.
Un giorno accadde. Si trovò circondato da quattro giaguari. Il quattro, simbolo della totalità. Ormai spacciato.
Fu lì che un dogo, il cane cacciatore dei giaguari, intervenne. La lotta fu furibonda, ma alla fine, seppur a caro prezzo, ebbe la meglio.
Non si lasciarono più, uno accanto all’altro, uno nell’altro.
A volte, quando la luce colpiva in una certa maniera gli occhi di quel cane, in fondo ad essi si poteva cogliere lo sguardo del bambino.
Due sogni aveva quel fanciullo, nel frattempo diventato un monaco guerriero. Diventare l’uomo della medicina, stregone e sciamano, ed imbarcarsi un giorno su una baleniera, per osservare le balene, i grandi cetacei, immergersi dinnanzi alle coste dell’Islanda, nelle profondità dell’abisso. Chissà poi perché?
Una storia era rimasta impressa nella sua mente. Si racconta che le piccole balenottere non affrontano da sole le acque gelide delle profondità. Hanno bisogno che la madre le accompagni, che s’immerga con loro. Quella mamma, che il bambino sentiva di non aver mai avuto.
Dopo quel viaggio, poteva pure morire.
Fu così che ebbe inizio
Fu così che ebbe inizio.
Un giorno cominciai a salire, ad arrampicarmi sulle rocce e, giunto in cima, davanti a me si aprì un giardino delizioso.
M’inoltrai. Il giardino diventò un bosco rigoglioso.
All’interno una piccola radura, con al centro un abisso. Un minuscolo ponte, senza parapetto, univa le due rive.
“Non passare oltre”, una voce sussurrava.
“Non ora, non posso”, dissi. “Ancora no”.
Poi la vidi. Una donna, una dominatrice, la regina del bosco.
Sembrava ostile. Che fare? Lottare con Lei? Potrei ferirla, o ferirmi.
Il guerriero presente in me si risvegliò. Quel guerriero cresciuto tra vetri taglienti, affilati come bisturi. Fu un attimo, poi si placò.
Era selvatica, di una bellezza selvaggia, con lunghi capelli incolti, seni sodi, con due capezzoli belli come boccioli di rosa.
Fu lì per attaccarmi ma, come per incanto, un grosso lupo comparve accanto a me. Digrignò i denti, e la donna rinunciò. Scomparve nel fitto della foresta.
“Non posso lasciarla, ora che l’ho incontrata”.
La fantasia può aiutarmi, forse la fantasia. Il narrare mondi, il rapirla raccontandole storie. Non voglio cambiarla, non voglio lottare con lei, non voglio soccombere, né farle perdere la sua individualità.
Amarla? Forse si. Sarà possibile?
Se le raccontassi della vita fuori dal bosco? Magari potrebbe nascere nel suo cuore il desiderio di conoscerlo. Potrei parlarle di un sicomoro e dell’incisione del guardiano dei sicomori, incisione capace di rendere dolcissimo un frutto amaro come il miele.
Forse …………… forse.
L'Ombra del Lupo
Dove è stato nel suo incessante girovagare?
Chi ha incontrato?
Una parte di lui si sentiva braccata, in fuga, violenta, solitaria. Capace di stupri, rapine e prevaricazioni.
Un odio sordido provava, profondo, primordiale, come per un capezzolo tolto, anzi mai dato.
Un odio che gli consentiva d’infilare una lama nel basso ventre, e poi di tirar su, a dilaniare tutto ciò che incontrava.
Solo nella notte chiamava, ma nessuno rispondeva.
Imparò a combattere.
E a sopravvivere.
Un giorno s’avvicinò ad una pozza d’acqua. Bevve avidamente, a lungo. La polvere del deserto, che si era incrostata nella sua gola, si sciolse. Alzò lo sguardo, si riposò, poi si apprestò a bere di nuovo. Fu in quel momento che accadde: vide un’immagine, spaventosa, riflessa nell’acqua. La sua.
Era un lupo famelico, nero, con gli occhi rossi invasi di sangue. Si ritrasse, si affacciò di nuovo: era sempre lì. Quell’immagine era ciò che gli rimandavano gli occhi di sua madre. Una madre che vedeva nei maschi, e quindi anche in lui, dei lupi famelici che la insidiavano.
Ne ebbe terrore, fuggì via.
Gli sono occorsi molti anni, e diverse vite, per ritrovare un po’ di sensibilità nel suo cuore.
Tanto l’ha aiutato l’incontro con una bella lupa, dal pelo folto, morbido e caldo. Finalmente poteva specchiarsi negli occhi di qualcuno, e trovare Amore.
Incontrò poi un Orango, che gl’insegnò a superare gli ostacoli, saltando da un ramo all’altro, così come a oltrepassare i propri limiti psicologici.
Ancora oggi però, in quei gelidi tramonti d’inverno, quando scruta l’orizzonte alla ricerca di qualcosa, sente ancora un misto di richiamo e nostalgia per quegli istinti devastanti ma vitali, che ancora emanano un fascino oscuro ed una preoccupante attrazione.
Sente sempre di camminare come sull’orlo di un baratro, e deve prestare attenzione a quell’orrido, che periodicamente fa sentire il suo richiamo.
Il bambino che diventò un lupo
C’era una volta un posto, un deserto, con la terra arida ed arsa e pochi alberi spogli.
Lì viveva un bambino con i calzoni corti ed i calzini bianchi, aveva forse otto anni ed era solo, immensamente solo.
A volte gridava, a voce alta, ma nessuno rispondeva.
Ci volle molto, molto tempo, ma alla fine si rassegnò, le lacrime si asciugarono ed il terrore della solitudine si stemperò.
Prese allora a camminare. Camminava sempre e a volte alzava lo sguardo verso il cielo, per trovare un po’ di conforto nell’idea che aveva del buon Dio.
Successe poi che un giorno vide in lontananza del fumo uscire da un comignolo: era una casa. Si avvicinò circospetto e da una finestra sbirciò dentro. C’era una tavola apparecchiata, con quattro scodelle, e c’erano due bambini, pressappoco della sua età.
Loro però non erano soli: due adulti li accudivano, i bimbi li chiamavano Mamma e Papà.
Fu allora che dopo molto tempo, senza comprenderne il motivo, i suoi grandi occhioni scuri si riempirono di nuovo di lacrime. Rimase parecchio tempo a guardare quello spettacolo, tanto che si fece notte e le candele nella casa furono spente.
Era una notte senza luna.
Andò via al buio e al gelo di una notte desertica, e continuò a camminare finché fu stanco.
Con le nude mani allora scavò una buca, una tana, e s’infilò dentro contento di quel poco tepore che le pareti, a contatto col suo corpo, gli restituivano. Dormì raggomitolato su se stesso, sognando un maestoso falco che si librava nel cielo.
Altre volte tornò nei pressi di quella casa, ma la soffernza era tanta e decise allora di andarsene per sempre.
Si rimise in cammino.
Non era più solo però, un grande falco volteggiava sopra la sua testa, sempre più vicino, finché un giorno si posò sulla sua spalla.
Successe poi che le orme dei suoi piedi, sulla sabbia, divennero quelle di quattro zampe.
Il bambino era diventato un lupo, un lupo forte solitario e ramingo, la sofferenza fu più sopportabile.
Si narra ancora di un lupo, grigio di pelo, che segue un falco, su e giù per le dune.
Girovagarono per anni, compagni di tante avventure, finché si fermarono davanti ad un grosso muro. Era il muro della diga. Al di là della diga, un oceano di acqua. No, non era acqua: erano tutte le lacrime del mondo.
Senza conoscerne il motivo, il vecchio lupo cominciò a piangere. Troppo a lungo aveva conservato quelle lacrime, il suo cuore poteva ora di nuovo sciogliersi. Pianse, pianse e pianse ancora, ed un rivolo di lacrime arrivò a bagnare la base del muro.
Fu allora che per effetto di quelle lacrime la diga si sgretolò, e tutto il dolore del mondo fu liberato.
Il vecchio lupo ne fu travolto, finalmente felice di essere libero, una goccia nell’oceano.
Da allora quel posto non fu più deserto, divenne un’immensa oasi verde, nella quale trovò riposo anche un magnifico vecchio falco.